



















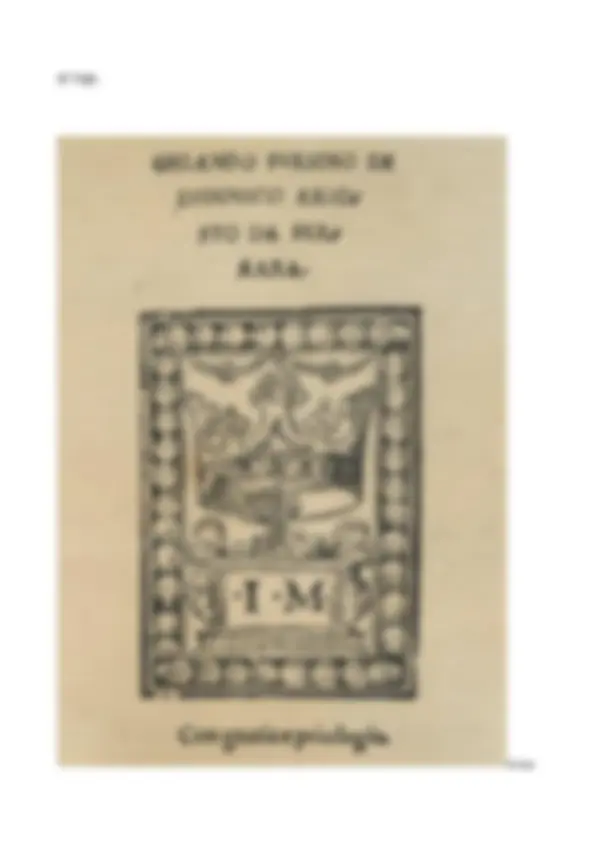
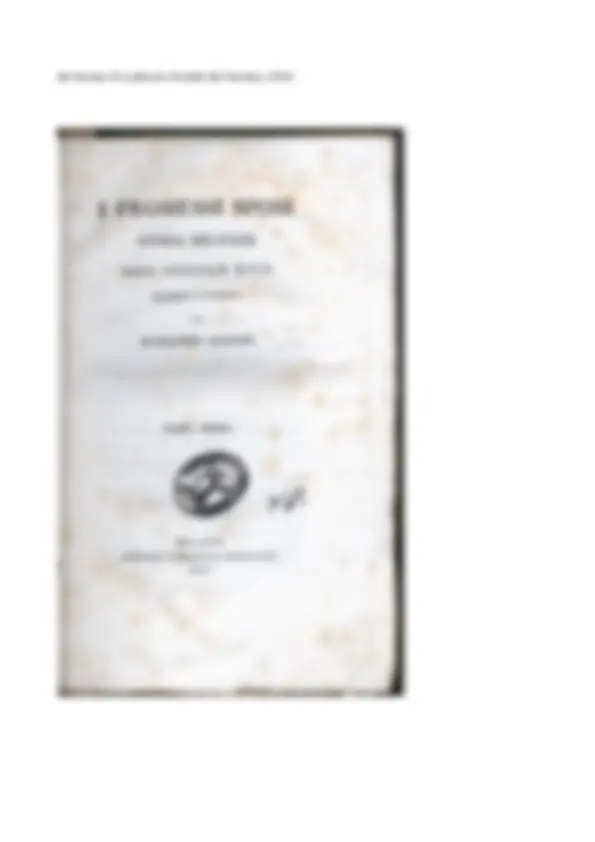
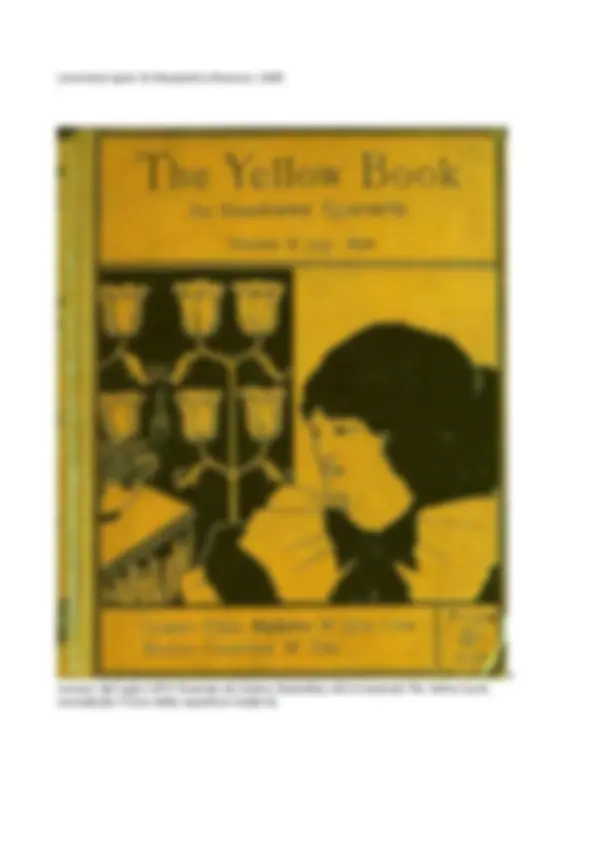
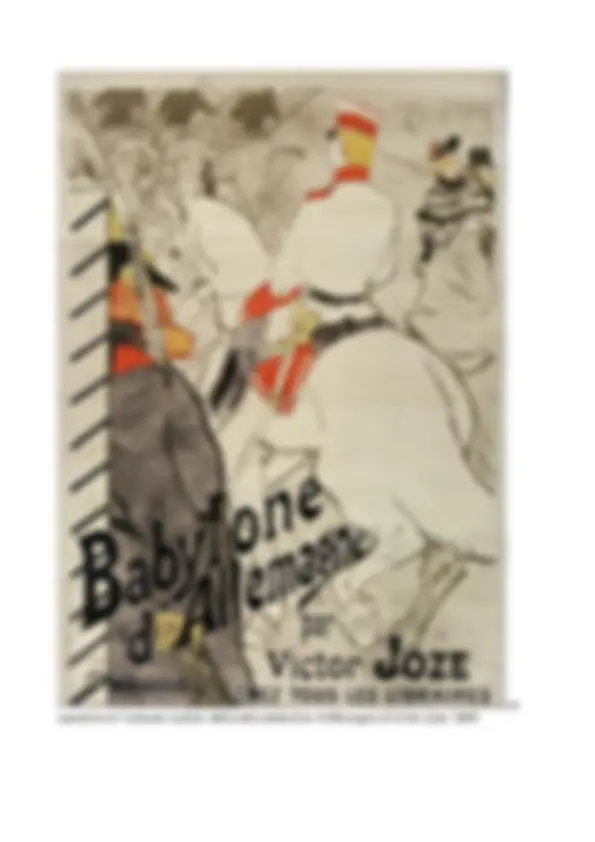




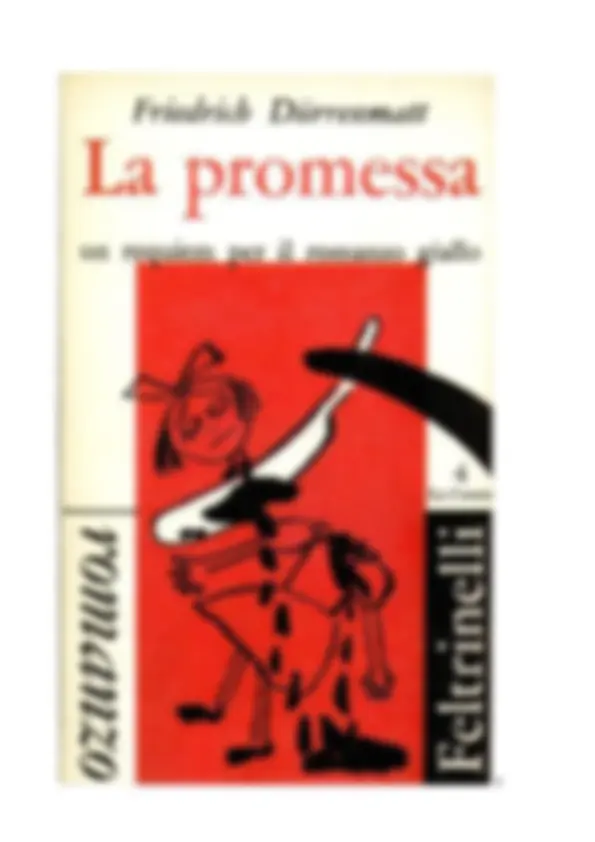















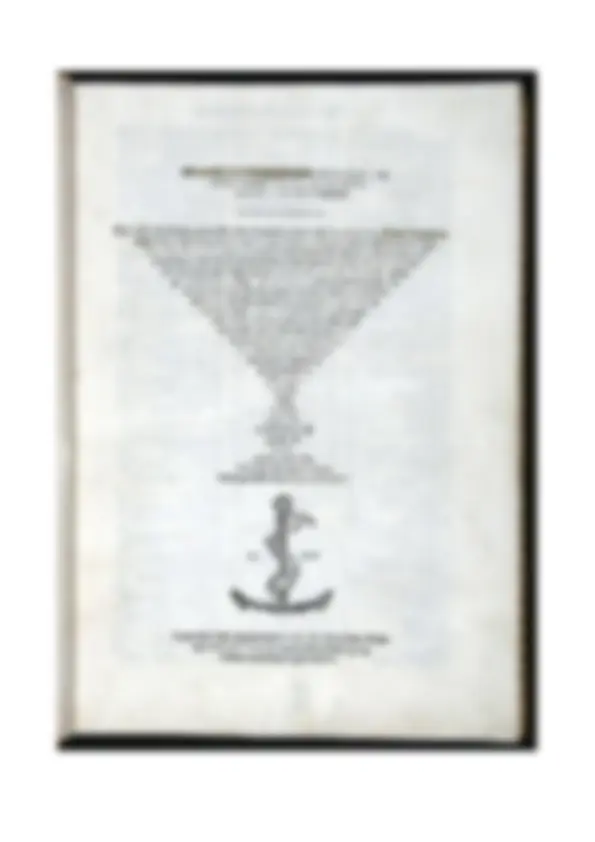






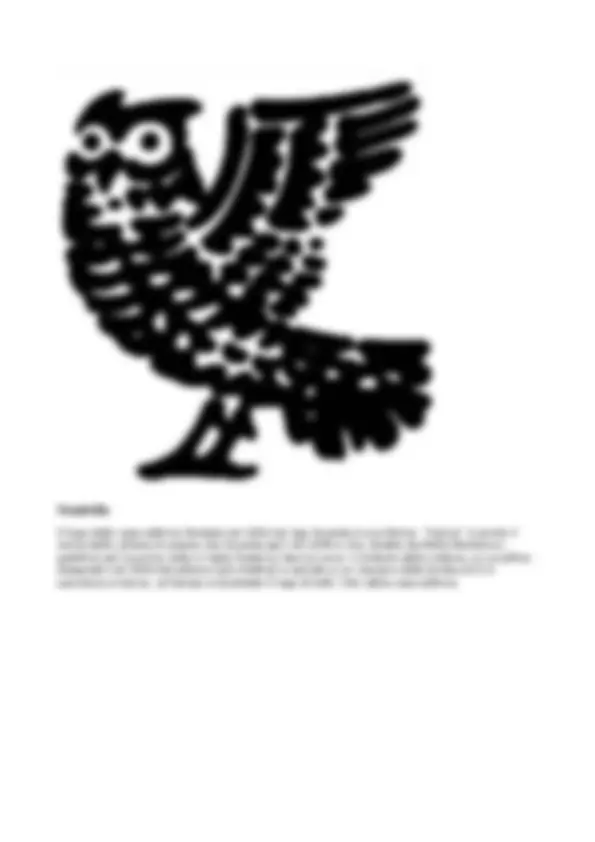


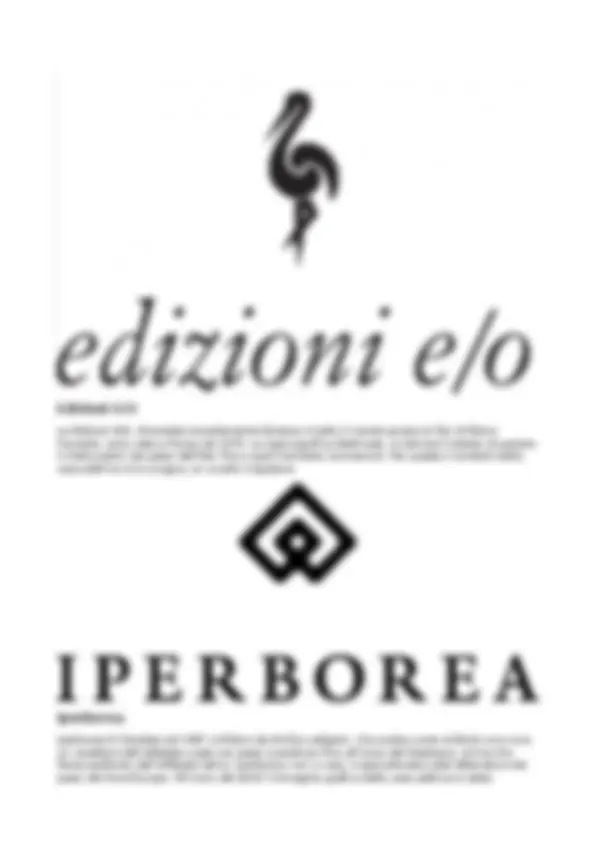
















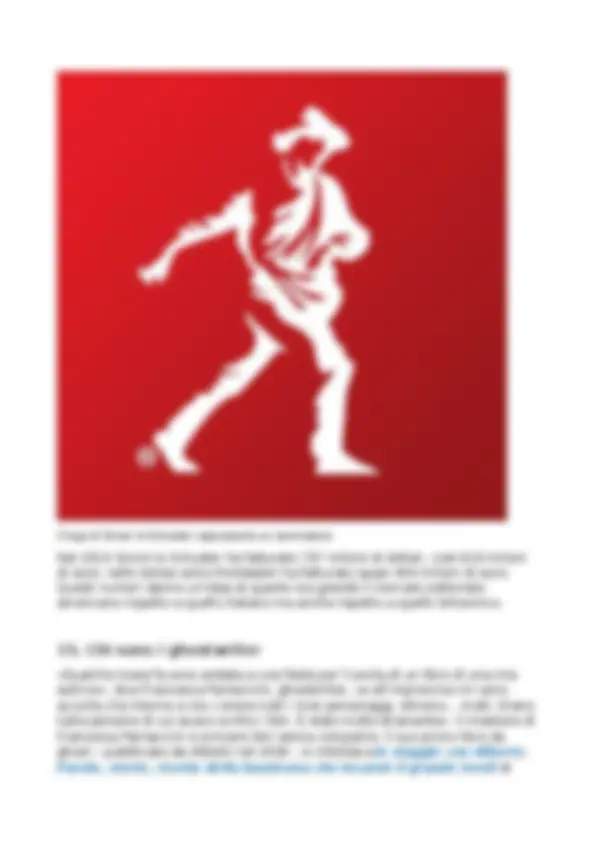























Study with the several resources on Docsity

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Appunti sul libro "Cose, spiegate bene. A proposito di libri"
Typology: Study notes

Limited-time offer
Uploaded on 11/02/2021
4.8
(9)2 documents
1 / 114

This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!




















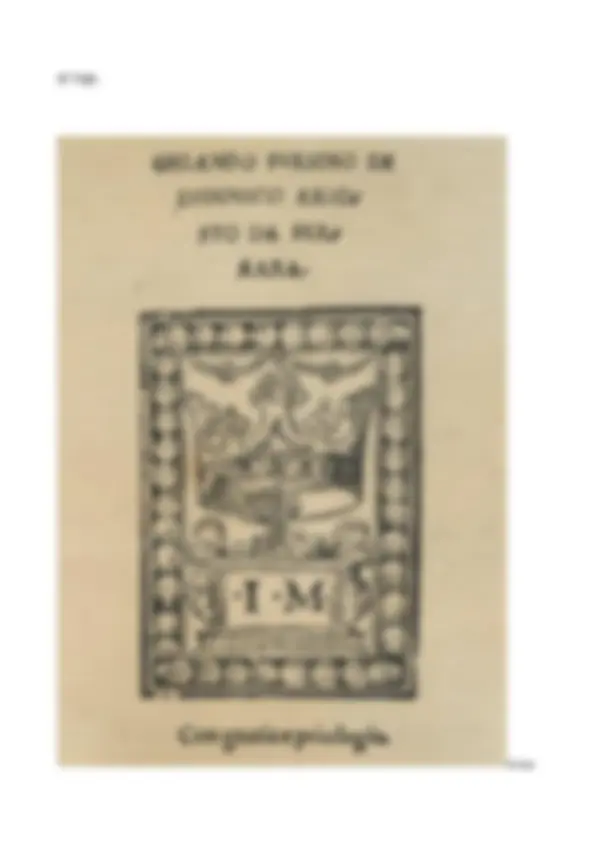
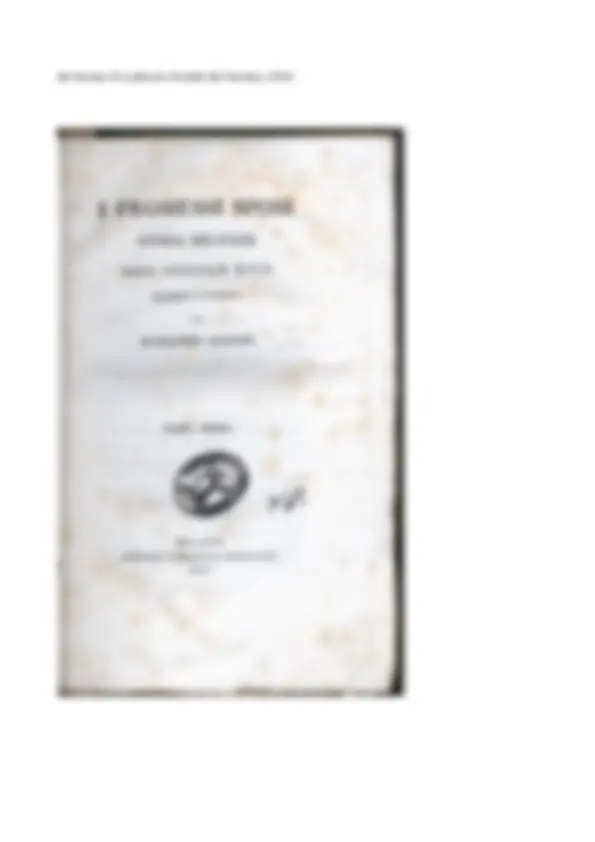
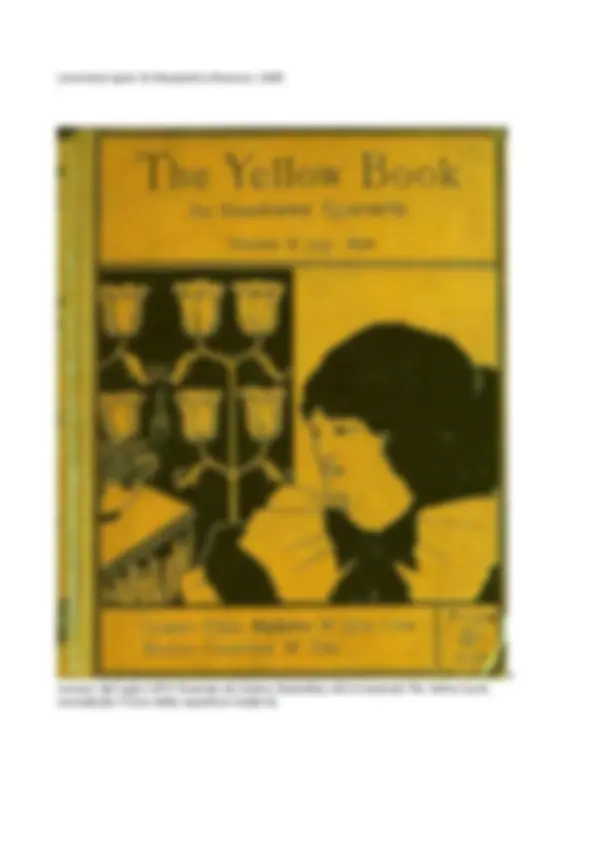
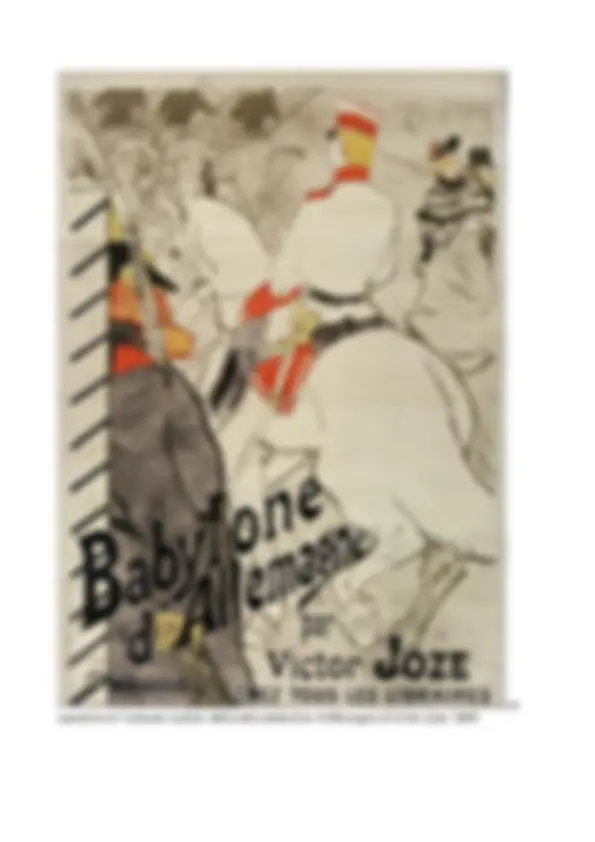




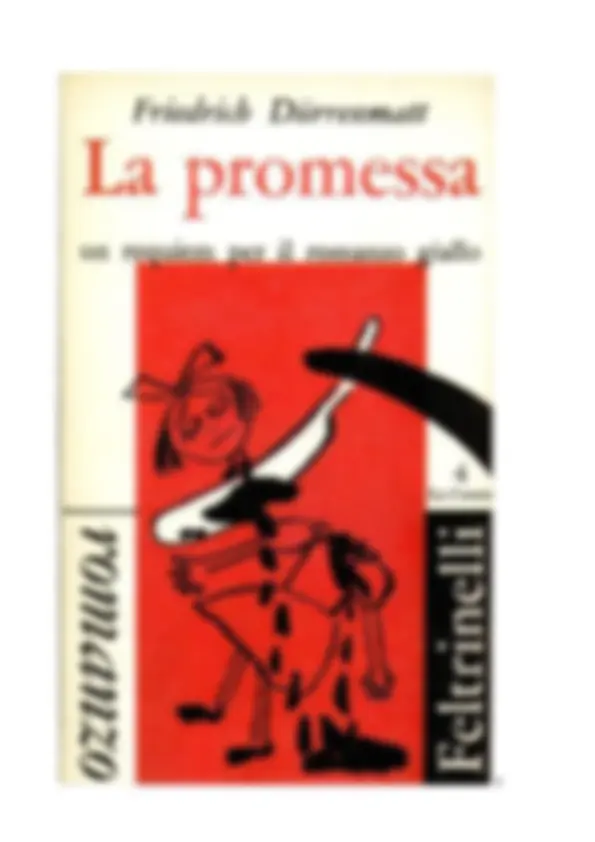















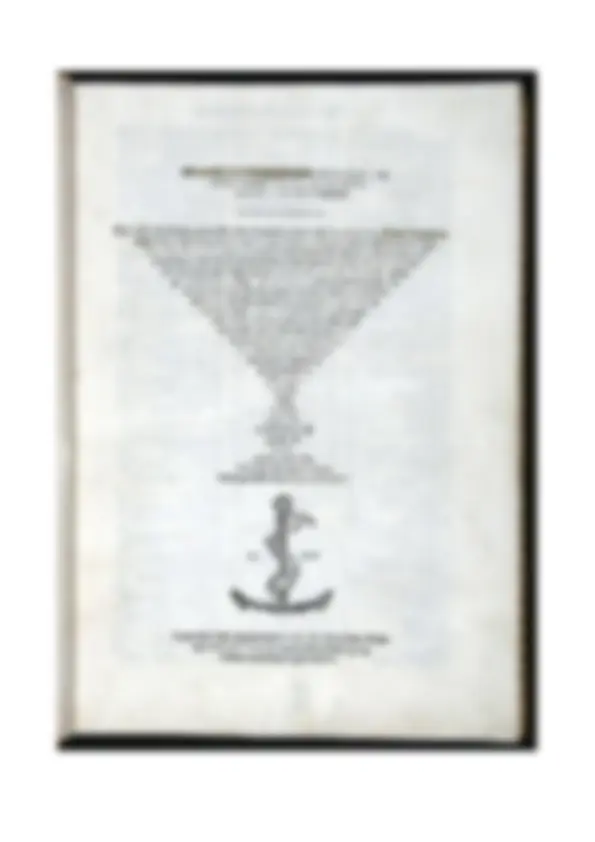






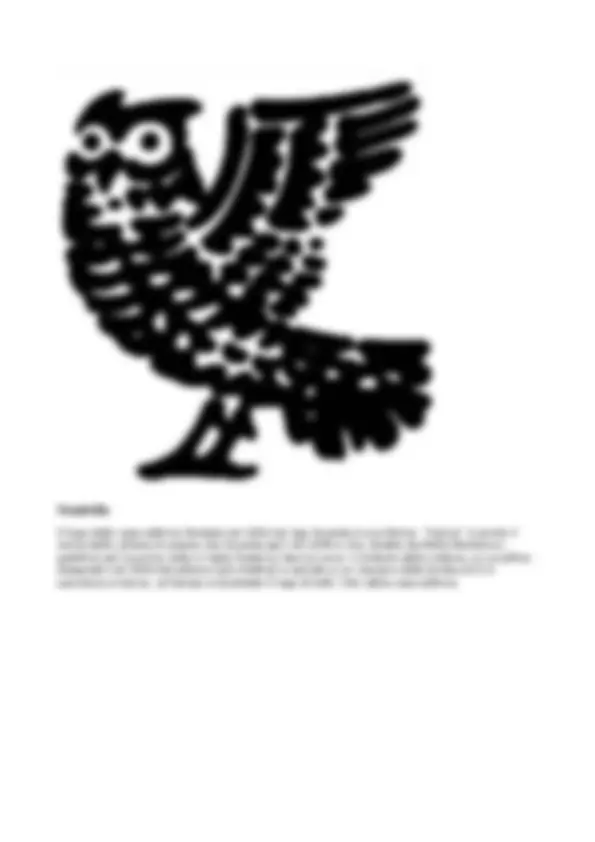


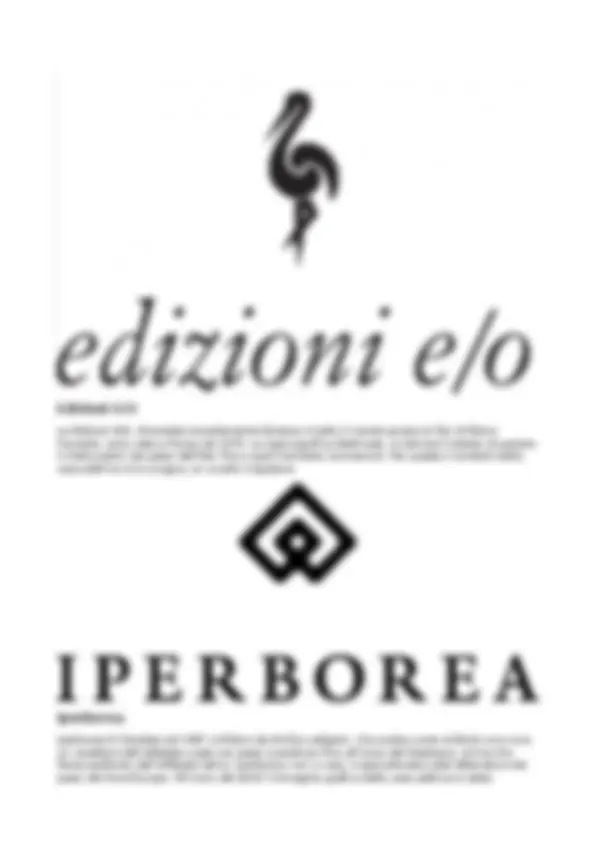
















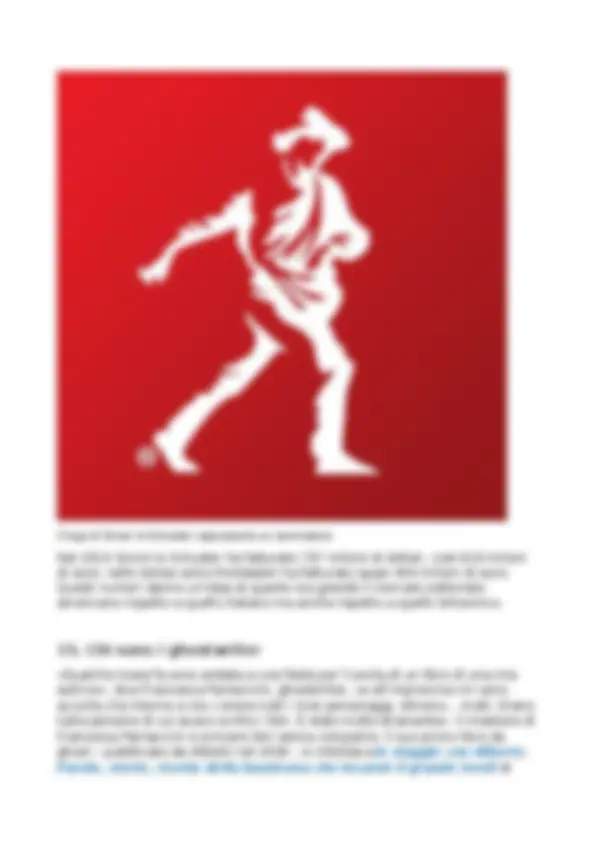






















On special offer
La carta è la materia di cui sono fatti i libri – oltre che i soldi, i quaderni e un sacco di altre cose – ma in pochi, sfogliando un libro, sono in grado di dire di che tipo di carta sia fatto. In altri campi non è così: le conoscenze tecniche elementari sono diffuse e gli esperti – o i sedicenti tali – proliferano. Quasi tutti sanno distinguere il denim dai tweed, la seta dal lino o il cachemire dall’acrilico, e negli ultimi anni si sono moltiplicati gli esperti di cibo e di vino. Nonostante la carta sia fondamentale per valutare i libri in quanto oggetti attraverso la vista, il tatto e l’olfatto, quasi nessuno sa dire perché un libro si sia ingiallito, quali siano gli editori che usano la carta migliore e se una copertina sia goffrata oppure marcata a feltro. Distinguiamo a stento la carta vetrata. Una copia di “Mémoires. Structures portantes d’Asger Jorn” di Guy Debord e Asger Jorn, i fondatori dell’Internazionale situazionista. Fu stampata a Copenhagen nel 1959. Nel 2011 una copia è stata venduta all’asta a Parigi da Christie’s per 3mila euro. Jorn disse allo stampatore Permild che la copertina in carta vetrata era stata pensata per minacciare i libri vicini sullo scaffale o per pulire tavoli di mogano.
In Italia l’industria della carta ha una tradizione antica e dimensioni importanti: secondo i dati diffusi dal Gruppo Burgo – il maggiore gruppo cartario
italiano, fondato a Verzuolo, Cuneo, nel 1905 – nel 2014 il fatturato della filiera della carta è stato di 31 miliardi di euro, di cui 9,5 da esportazioni, per 716 mila posti di lavoro. Per avere un parametro: secondo Mediobanca nel 2012 lavoravano nella moda 465.500 persone. Anche se la carta per libri non è il suo prodotto più forte, nel 2014 il settore carta di Burgo ha fatturato 1, miliardi di euro, come il Gruppo Diesel nella moda nel 2013. Il 75 per cento della carta italiana viene prodotta in Versilia, nella zona di Capannori, in provincia di Lucca, ma si tratta per lo più di carta igienico-sanitaria, su cui quindi è difficile stampare. Il più antico e importante produttore italiano di carta di qualità è il Gruppo Fedrigoni di Verona, che nel settore della carta di lusso è anche uno dei più forti a livello europeo e mondiale. Nel 2014 Fedrigoni – che ha 2.700 dipendenti e 13 stabilimenti di cui 9 in Italia – ha fatturato 873 milioni di euro, appena meno meno di Tod’s e D&G. La prima cartiera fu fondata da Giovanni Fedrigoni nel 1724 a Trambileno, vicino a Rovereto. Tre secoli più tardi, nel 2002, Fedrigoni ha acquisito dal Poligrafico di Stato le Cartiere Fabriano, le più antiche del mondo ancora in attività, fondate nelle Marche nel 1264, un anno prima che Dante Alighieri nascesse. Fedrigon-Fabriano, oggi, è uno dei maggiori produttori mondiali di cartoncini di lusso, scatole per profumi e carta adesiva (anche le figurine Panini), carta per libri illustrati e per libri normali pubblicati da editori attenti alla carta. Il prodotto più noto di Fabriano sono gli album da disegno, compresi i preziosi fogli per acquerelli e incisioni, quello meno conosciuto sono le banconote, di cui il gruppo è l’unico produttore italiano. «La carta per acquarelli o incisione e quella dei soldi sono molto simili, tutte cotone, senza tracce di legno. Questi tipi di carta e la carta moneta sono sorelle», dice Chiara Medioli, direttrice marketing e discendente del fondatore.
La carta si ottiene dalle fibre disidratate di cellulosa – un polimero presente in natura da cui si estraggono molti altri materiali, tra cui il diacetato delle montature degli occhiali, il rayon o il cellophane – che vengono sciolte nell’acqua fino a formare una pasta che si può stendere in fogli. «È come stendere la sfoglia dopo avere mischiato acqua e farina. La carta ha molto in comune con la cucina», dice Medioli. «Ogni tipo di carta ha una ricetta, spesso segreta. Dipende dal tipo di cellulosa utilizzata, se è carta di cellulosa, derivata da fibre che si usano nel tessile come lino o cotone, oppure estratta dal legno, e dal tipo di legno, dai minerali nell’impasto e dai procedimenti chimici a cui è stata o non è stata sottoposta». La cellulosa – (C 6 H 10 O 5 ) n – viene commerciata sotto forma di foglioni da sciogliere nell’acqua, eventualmente insieme a minerali, come il carbonato di calcio, il talco o il caolino, quello che si usa per fare la porcellana. Questi fogli di cellulosa possono essere bianchi o avorio a seconda del colore della carta che si vuole ottenere. La carta più preziosa deriva dalla cellulosa fibrosa, che viene estratta da piante come il cotone o la canapa, mentre quella del legno
L’uso massivo del legno incomincia ad diffondersi con la Rivoluzione industriale, a partire dal Settecento, quando si forma un’opinione pubblica di lettori, nascono i giornali a grande tiratura e i primi bestseller, come il romanzo epistolare Pamela di Samuel Richardson. Per vendere i libri al maggior numero possibile di persone bisogna contenere i costi, lavorando sui materiali e sui processi di produzione. In questa fase la storia della carta si sovrappone a quella della tipografia e delle grandi invenzioni del periodo: Giambattista Bodoni, l’inventore del carattere tipografico utilizzato da Franco Maria Ricci, entrò in contatto con la cartiera Miliani di Fabriano; John Baskerville, l’inventore del carattere tipografico dei libri di Adelphi , per molto tempo fu ritenuto anche l’inventore della carta velina che fu portata in Francia – da dove si diffuse in tutta Europa – da Pierre Montgolfier, il padre dei fratelli della mongolfiera. L’opinione pubblica vuole leggere e scrivere, e le tipografie hanno bisogno di stampare, ma più la carta diventa importante e centrale, e più se ne produce e vende, più la qualità media peggiora. Già nell’Ottocento la carta è diventata un prodotto industriale.
La carta si divide in due grandi categorie: naturale e trattata. La carta naturale – o usomano , perché è quella dei quaderni, cioè per scrivere a mano – è quella che normalmente viene usata anche per gli interni dei libri. La qualità, ovviamente, varia moltissimo a seconda della quantità di lignina, e della lunghezza delle fibre che dipende dal tipo di albero da cui è estratta la cellulosa. Pini, abeti, cioè le conifere, hanno la fibra lunga, mentre aceri, faggi, eucalipti (latifoglie) hanno la fibra corta e quindi producono carte più opache. Esistono anche carte naturali – le più preziose – ricavate da cellulosa pura, senza lignina. A dispetto del suo nome, la carta naturale viene sottoposta a collatura, sulla superficie viene cioè stesa una patina di colla per non fare sbavare l’inchiostro. A meno di casi particolari e rari, l’interno dei libri in commercio è di carta usomano. Le carte trattate possono essere: patinate marcate a feltro goffrate o vergate filigranate In editoria le carte trattate vengono in genere utilizzate per le copertine. Le carte patinate sono quelle che si usano per le riviste tanto che, per estensione, l’aggettivo “patinato” è diventato sinonimo di elegante e prezioso. Invece la patina è ottenuta aggiungendo alla cellulosa una quantità di carbonato di calcio, cioè sasso in polvere, che si aggira intorno al 30 per cento. Ne consegue che questo tipo di carta pesa di più, ma a parità di
peso costa meno, perché il calcio è meno caro della cellulosa. Ed è quindi molto meno preziosa ed elegante degli altri tipi di carta trattata. Le carte marcate a feltro sono quelle che si ottengono stendendo i fogli ancora bagnati su tappeti di feltro in modo da riprodurne il disegno e le irregolarità. È un tipo di carta che viene spesso utilizzata in editoria perché al tatto dà una sensazione di matericità e porosità che altre carte non danno. A Villar Pelice, vicino a Torino, c’è un museo del feltro e un’ azienda che li produce. La carta goffrata o vergata viene fatta passare a secco dentro dei rulli che imprimono un disegno più regolare di quello lasciato dal feltro. La differenza tra vergato e goffrato dipende dal tipo di disegno. Anche questo tipo di carta è usato in editoria, soprattutto sulle copertine. Infine la carta può essere vergata con la filigrana: è il caso delle banconote, ma anche di carte speciali di libri preziosi o di album da disegno che lasciano intravedere un disegno all’interno. A differenza delle carte marcate a feltro o goffrate, nel caso della filigrana il disegno è nell’impasto e non impresso a posteriori sulla carta.
La carta si vende a peso, che è espresso in grammi per metro quadrato. Il cosiddetto PPB – Paper Printing and Binding , quindi carta, stampa e rilegatura – incide per circa l’8 per cento sui costi totali di un libro. Significa che la carta incide mediamente per circa un terzo di quella percentuale, ovvero dal 2 al 4 per cento. Il costo della carta però può variare moltissimo: si va dalle 700 euro a tonnellata della carta più scarsa, quella per fare fotocopie, ai 1500 euro di una carta preziosa. Naturalmente l’incidenza varia anche a seconda della quantità di copie stampate, del numero di pagine e delle dimensioni finali del libro, che però dipendono anche dal tipo di carta: se per esempio il testo è troppo corto perché il libro possa apparire un oggetto dignitoso, l’editore può decidere di renderlo più alto, aumentando la grammatura della carta – cioè lo spessore. Un altro procedimento consiste nel “gonfiare” la carta, aumentandone lo spessore a spese della densità: in questo caso si parla di «carta bouffant». È il caso di quei libri che pesano molto meno di quanto uno si aspetterebbe. La qualità della carta – insieme alla rilegatura che può essere cucita a mano o incollata – rimane l’indicatore principale, anche se invisibile, della raffinatezza dell’edizione.
I libri d’arte e i cosiddetti «coffee table books», cioè i libri da arredamento, hanno spesso carte preziose, anche se le carte patinate possono ingannare. Tra gli editori italiani di libri da leggere il più attento alla carta è Sellerio. I libri di Sellerio hanno un formato ridotto proprio perché altrimenti alcune collane costerebbero troppo per avere prezzi competitivi. Quasi ogni collana è associata a un particolare tipo di carta prodotta dalle Cartiere Miliani di
Gli interni dei libri Einaudi – il cui bianco spinse i fondatori di Adelphi alla imitlin colorata della Piccola Biblioteca – sono in normale carta usomano avoriata. Il colore avorio ha la funzione di diminuire la trasparenza delle pagine e, quindi, di migliorare la lettura. Le collane più importanti e costose, invece, sono definite anche dalla carta: l’interno dei Millenni e della NUE – Nuova Universale Einaudi – è in carta Fedrigoni Arcoprint , le copertine di cartone dei Coralli e Supercoralli sono rivestite ancora in imitlin , quelle dei Millenni e delle Grandi Opere in tela, le Letture sono in carta Simply Cotton. Carta Ingres vergata della collana La Memoria di Sellerio La copertina in imitlin dei Coralli e Supercoralli di Einaudi (Fabriano) Una copertina di Iperborea in imitlin
La Fabriano Grifo vergata avorio, utilizzata nelle pagine interne di Sellerio (Fabriano) Una copertina in imitlin della Piccola Biblioteca di Adelphi La carta Acquarello rigata marcata feltro su entrambi i lati delle sovracopertine della Biblioteca Adelphi
Prima che su quello che c’è scritto dentro, la forza di un libro si basa su tre fattori: quello che si vede, quindi il formato, la grafica della copertina e in trascurabile proporzione il carattere di stampa ; quello che si tocca, quindi la carta, se sia ruvida o liscia, sottile o spessa; e l’odore, che è l’elemento più inafferrabile e, forse per questo più romantico, per gli amanti dei libri. L’amore per l’ odore della carta stampata è diventato il simbolo della nostalgia per un mondo che scompare al punto che è proclamato anche da un mondo – come quello della moda – che per i libri e la stampa non ha mai mostrato particolare trasporto. Nel 2012 Karl Lagerfeld e Wallpaper hanno lanciato Paper Passion Perfume , un profumo ispirato proprio a quello della carta, « for booklovers ». In realtà chiunque lavori nella produzione della carta e della stampa ti spiega che l’odore di un libro dipende da troppe variabili per potere essere controllato e riprodotto. «Che mi risulti», dice Chiara Medioli di Fedrigoni-Fabriano, «nessun editore si è mai troppo occupato dell’odore dei suoi libri, che dipende dall’umidità, dall’età del libro, da dove è stato conservato, dal tipo d’inchiostro, dalla carta e da come tutti questi fattori interagiscono tra loro».
2. I mestieri del libro Editore
Amministratore Delegato Direttore Editoriale Editor: Consiglia allo scrittore di accorciare tagliando parti inutili o che rallentano, o a cambiare parole a cui è affezionato Consulente Capo Redattore Redattore Correttore di Bozze Lettore Traduttore Art Director Grafico Marketing Ufficio Stampa Commerciale Agente della rete di vendita Amministrazione Ufficio Contratti Agente Letterario Ufficio Diritti Ufficio Tecnico Scout Digital Manager Social media manager 3.1 (Quasi) tutti i libri italiani sono in Garamond “I caratteri sono gli atomi dell’editoria, l’elemento base della comunicazione stampata, come i mattoni per l’architettura o le note per la musica. Tutti li vedono, ma raramente qualcuno li guarda.” - Cose spiegate bene. A proposito di libri Quasi tutti i libri italiani sono in Garamond, anzi, per essere più precisi, in Simoncini Garamond, un carattere disegnato da un tipografo francese nel Cinquecento – Claude Garamond – e rimaneggiato da un tipografo bolognese
Il Garamond di Einaudi Il Baskerville di Adelphi I caratteri sono gli atomi dell’editoria, l’elemento base della comunicazione stampata, come i mattoni per l’architettura o le note per la musica. Tutti li vedono, ma raramente qualcuno li guarda. Eppure rappresentano letteralmente il carattere di un testo e la faccia di un libro. In inglese, infatti, «carattere» si dice « type-face », mentre il temine «font» deriva dal francese medievale «fonte», che significa «fuso», l’etimologia è quella di fonderia. Il riferimento è alla macchina a caratteri mobili inventata da Johannes Gutenberg nel 1454 (o 1455) che ricavava i caratteri, appunto, dalla fusione del metallo. La storia dell’editoria scorre parallela a quella storia della stampa. Aldo Manuzio – che è considerato il primo editore moderno e di cui quest’anno si celebrano i cinquecento anni dalla morte – non sarebbe diventato così famoso senza i caratteri disegnati per lui da Francesco Griffo , un altro tipografo bolognese, che all’inizio del Cinquecento inventò il corsivo, che in inglese si chiama italic proprio perché fu inventato in Italia. Ai caratteri di Griffo qualche decennio più tardi si ispirò Claude Garamond , un tipografo e incisore di caratteri francese che divenne famoso nel 1541 per avere disegnato il “Grec du roi”, il carattere greco usato per i libri in greco destinati al re di Francia Francesco I di Valois. Qualche anno dopo arrivò il
carattere romano da cui sarebbero derivati tutti i Garamond successivi, che sono decine (qui c’è un articolo in francese o inglese dove trovate di tutto). Il tema dei caratteri tipografici è talmente ampio, le differenze così sottili e invisibili ai non esperti, che semplificarlo è rischioso, ma sostanzialmente si può dire che l’interno dei libri italiani – e dei libri in generale – è molto molto simile a com’era cinquecento anni fa. La prima grande divisione è tra caratteri graziati ( serif in francese significa “grazia”) e bastoni ( sans serif). I bastoni sono quei caratteri – come l’ Helvetica , l’ Arial , il Grotesk , il Franklin Gothic , il Verdana , l’ Univers e il Futura – che hanno linee diritte e dello stesso spessore, senza abbellimenti o “grazie”, appunto. Furono inventati molto più tardi dei graziati, dall’Ottocento in poi, e vengono utilizzati per le copertine dei libri, le pubblicità, i marchi e i testi su Internet, quasi mai per testi lunghi stampati su carta. Il capostipite dei bastoni è il Grotesk del 1832, ma il più famoso – quello che segnò un cambio d’epoca – è il Futura, disegnato da Paul Renner nel 1927, e ispirato dal movimento architettonico Bauhaus. Negli anni 50 dalla Svizzera giunsero l’Univers (1956, Adrian Frutiger) basato sullo Standard Medium dell’ Akzidenz Grotesque del 1896 e, soprattutto, l’Helvetica (1957, Max Meidinger), che per i bastoni è considerato ciò che il Garamond è per i graziati. I graziati si chiamano così perché alle estremità presentano delle “grazie”: piccoli ganci, minuscoli piedistalli, ispessimenti e assottigliamenti, abbellimenti, insomma, che attutiscono il baratro tra nero e bianco, cuciono insieme le lettere tra loro e rendono i libri più fluidi e leggibili. Le grazie sono la transizione verso il corsivo, il tentativo di tenere insieme i caratteri mobili. I graziati si dividono a loro volta in antichi e moderni: quelli antichi – come appunto il Garamond , il Bembo , il Palatino o il Sabon – sono caratterizzati da scarsa differenza nello spessore tra aste verticali e orizzontali, e dalla presenza di grazie concave, cioè grazie che si raccordano alle aste disegnando curve. Se oggi i “raccordi” delle grazie dei libri che leggiamo sono arrotondati, si deve al fatto che tutti i graziati derivano da un unico carattere – il lapidario romano – e che agli scalpellini che scolpivano le iscrizioni sui monumenti dell’Antica Roma veniva molto più facile incidere curve piuttosto che angoli retti. Altro carattere
Negli anni Ottanta arrivò la fotocomposizione. I testi non dovevano più essere composti, bastava fotografarli: i caratteri mobili non avevano più senso di esistere. La stampa perse progressivamente il suo contatto con la fabbrica, l’inchiostro e la fatica. Pochi anni dopo avvenne un’altra rivoluzione: con la tecnologia PostScript dei personal computer non c’era nemmeno più bisogno della fotografia, tutto diventava immateriale, digitale, elettronico. Microsoft cercò di comprare il carattere Helvetica, ma la Haas, la società svizzera proprietaria del carattere, non prese nemmeno in considerazione l’offerta. Così Microsoft commissionò un carattere equivalente : l’Arial nacque così. Oggi l’Helvetica è il carattere del sistema operativo del Mac. Nel 1972 al Reed College Steve Jobs si iscrisse a un corso di lettering tenuto da un monaco trappista di nome Robert Palladino. In un discorso alla Stanford University del 2005 Jobs raccontò: «Imparai la differenze tra caratteri graziati e non graziati, sul variare la quantità di spazio tra le combinazioni di lettere, su ciò che rende grande la grande tipografia. Era bello, storico, sottilmente artistico in un modo che la scienza non può afferrare, e lo trovavo affascinante. Niente che avrebbe avuto nemmeno una speranza di trovare un’applicazione pratica nella mia vita. Invece dieci anni dopo, quando stavamo progettando il primo computer Macintosh, mi ritornò in mente e mettemmo tutto nel Mac». Nel 1984 il Macintosh permise di vedere sullo schermo, per la prima volta, quello che sarebbe andato in stampa. Dopo cinque secoli di stampa , scrivere e comporre coincisero: per stampare bastava rileggere e premere Invio e il foglio elettronico si sarebbe trasformato in un foglio di carta. Il carattere ufficiale di Apple nel 1984 era l’ITC Garamond, che è diverso dal Simoncini, ed è detestato da alcuni, ma appartiene ancora alla stessa famiglia. Nel 1985 arrivò Pagemaker, il primo programma di impaginazione per personal computer realizzato dalla Aldus Corporation, che si chiama Aldo in onore di Aldo Manuzio. L’Adobe Garamond venne invece disegnato nel 1989 da Robert Slimbach. Non c’è niente di resistente come i caratteri di stampa. A guardarli da vicino trasportano ancora scalpellini romani, stampatori rinascimentali, artisti novecenteschi e inventori di computer. Verba volant, scripta manent , dicevano quelli. Mentre la stampa cambiava, i libri sono restati immobili e i loro vecchi interni in Simoncini Garamond, nel frattempo, sono ridiventati nuovi. 3.2 I font preferiti dagli scrittori italiani Quasi tutti i libri italiani sono stampati in Simoncini Garamond , un carattere disegnato dal tipografo francese Claude Garamond nel Cinquecento, ed è forse uno dei motivi per cui è uno dei font preferiti dagli scrittori italiani per scrivere i loro libri, seguito dal Times New Roman, più moderno e onnipresente sui giornali e online.
I font sono tra i pochi strumenti da lavoro di uno scrittore e sapere che sulla pagina si srotolerà quello giusto – in un pacchetto che include grandezza, spaziatura e impaginazione del testo – può essere rassicurante, se non una condizione necessaria per scrivere, come ha confermato la maggior parte degli scrittori con cui abbiamo parlato. Tra loro c’è chi scrive sempre con lo stesso carattere, come Alessandro Baricco, chi lo ha cambiato nel tempo come Giorgio Fontana, chi usa il Times New Roman per romanzi, articoli e racconti come Valeria Parrella e chi lo detesta come Antonella Lattanzi; Walter Siti e Paolo Cognetti scrivono la prima stesura a mano, Teresa Ciabatti apre il foglio di testo e usa quello che c’è. «Garamond. Sempre. Non posso scrivere con altro font. Testo allineato a sinistra, non giustificato». Alessandro Baricco, nato a Torino nel 1958, è uno dei più famosi scrittori italiani contemporanei. Tra i suoi libri più noti ci sono Oceano Mare , il monologo Novecento da cui Giuseppe Tornatore trasse La leggenda del pianista sull’oceano e i saggi che spiegano il mondo di oggi: I Barbari , nel 2006, e The Game del 2018. «Io uso sempre Times New Roman 14, interlinea 1.5 rientro 1.5 giustificato ovviamente rientro a sinistra 1.5 e a destra lo stesso. Perché così mi viene una cartella da 1800 battute più o meno e questo lo uso per i libri, per gli articoli di giornale e per tutto, perché sono capricorno ascendente capricorno. No questa è una stronzata, però sono una proprio precisa e mi piace avere le cose precise. Prendo pochissimi appunti, a penna quasi mai, e scrivo solo al computer, sostanzialmente. Non prendo mai appunti sul telefonino, qualche cosa mi capita di prendere a penna ma è veramente rarissimo, piuttosto leggendo altri libri mi può capitare di utilizzare le ultime pagine per scrivermi qualcosa che mi viene in mente leggendo libri di altri». Valeria Parrella, nata a Torre del Greco nel 1974, ha scritto racconti, romanzi e opere teatrali che sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco e altre lingue ancora. Il suo esordio è del 2003 con la raccolta di sei racconti Mosca più balena , per cui vinse il premio Campiello opera prima; nel 2005 un’altra raccolta di racconti, Per grazia ricevuta , arrivò in cinquina al premio Strega, il più importante premio letterario italiano; nel 2008 pubblicò il suo primo romanzo, Lo spazio bianco , da cui Francesca Comencini trasse
«Times New Roman corpo 14, interlinea minima valore 21, rientro prima riga 0,25 cm, rientro a destra 2,4 cm, allineamento giustificato. È tutto collegato, non è solo il corpo o il font». Nicola Lagioia, nato a Bari nel 1973, ha vinto il Premio Strega nel 2015 con il romanzo La ferocia (2014), un noir contemporaneo ambientato in Puglia per cui vinse anche il premio Mondello. Dal 2016 è direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra gli altri suoi libri ci sono il romanzo Occidente per principianti (2004) e Riportando tutto a casa (2009). Ha diretto nichel , la collana di letteratura italiana della casa editrice minimum fax, ed è tra i conduttori di Pagina3, la rassegna culturale di Rai Radio 3. «Allora, è molto semplice: ho scritto l’inizio della mia tesi di laurea (1993) con una Olivetti portatile, che mi ero portato anche in Russia. Ho finito (1995) con il computer e non sono più tornato alla macchina da scrivere, non so nemmeno dov’è. Quando ho cominciato a scrivere dei libri (1996) ho usato il carattere Times New Roman corpo 14, che uso ancora, tranne che in un caso, un romanzo in terza persona, un giallo, abbastanza diverso dalle cose che ho scritto negli anni precedenti, che dovrebbe essere il primo di una serie, che ho cominciato a scrivere nel 2018 e che uscirà a fine aprile per Salani (si intitola Che dispiacere ). Per quello ho usato America Typewriter (corpo 14), che credo di usare anche per i successivi di questa serie. Ho un sacco di quaderni, grandi e piccoli, mi piace molto scrivere a mano, prendere appunti, non mi piace scrivere sul telefono, mi piacciono i taccuini, le penne, è un’altra cosa, ho l’impressione che la qualità del gesto determini il fatto che l’appunto poi viene meglio, lo so che mi sbaglio e mi piace sbagliarmi». Paolo Nori, nato a Parma nel 1963, è scrittore e traduttore, collabora con molti giornali e riviste, ha un blog personale e uno anche sul Post. È un esperto di letteratura russa: ha tradotto Lermontov, Gogol, Turgenev, Tolstoj e molti altri. Ha scritto moltissimi libri, romanzi, fiabe, racconti, discorsi e curato Repertori di matti di varie città (tra cui Milano , Roma e Bologna ); organizza seminari, viaggi letterari in Russia e legge spesso – con uno stile peculiare e con molti estimatori – libri e articoli suoi e di altri. Il suo primo libro è Le cose non sono le cose , uscito nel 1999; l’ultimo è il saggio La grande Russia portatile , del